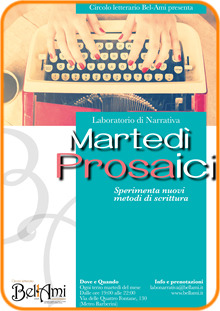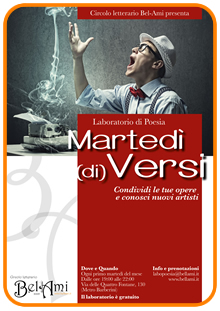Laboratorio di poesia


Haiku oulipistes
Laboratorio sperimentale
Durante gli incontri mensili della prossima stagione, vogliamo raccogliere una sfida inedita: creare una serie di haiku, applicando i meccanismi della poesia combinatoria,
Per farlo, utilizzeremo il metodo ed i principi propri del movimento dell’”OU.LI.PO.” (www.oulipo.net), meglio noto come l’Officina della Letteratura Potenziale, fondato a Parigi nel 1960 da Raymond Queneau e François Le Lionnais.
1 giornata (mar 10 ottobre 2023)
– Presentazione del laboratorio e degli obiettivi creativi sperimentali finali: macchine oulipistes
– Introduzione allo Haiku: l’antica e più nota forma poetica giapponese. Cosa (NON) è un Haiku.
– Laboratorio Creativo:
– gli haiku di Basho.
– scrittura di due haiku individuali.
– riferimenti bibliografici per l’approfondimento.
2 giornata (mar14 novembre 2023)
– Gli strumenti per la costruzione di un haiku:
– Lo stimolo a partire: lo stato d’animo
– la sillabazione metrica e grammaticale
– Laboratorio Creativo:
– gli haiku di Buson, Issa e altri autori giapponesi.
– scrittura di due haiku a gruppi di due a partire da una visione comune.
3 giornata (mar 12 dicembre 2023)
– Introduzione al movimento OU.LI.PO. (OUvroir de LIttérature POtentielle): la rivoluzionaria Officina di
Letteratura potenziale, fondata a Parigi negli anni ’60
– Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes.
– La poesia combinatoria: le cinque regole per l’adattamento di variabilità.
di una stessa (8 combinazioni) e adattamento condiviso.
– Laboratorio Creativo:
– adattamento condiviso (per 8 combinazioni potenziali) dei due haiku scritti nell’incontro precedente dai singoli gruppi, secondo il metodo della poesia combinatoria (sperimentale).
– riferimenti bibliografici per l’approfondimento
4 giornata (mar 9 gennaio 2024)
– Italo Calvino e il movimento dell’”OU.LI.PO.”.
– La poesia combinatoria: ancora sulle cinque regole per l’adattamento di variabilità.
– Gli strumenti per la costruzione di un haiku:
– Kigo, Kidai e piccolo Kigo: il riferimento stagionale
– Il Kireji e lo stacco semantico
– Laboratorio Creativo:
– gli haiku dei poeti occidentali: Sanguineti, Seferis, Kerouak e gli altri.
– Scrittura o riscrittura degli “haiku oulipistes”, precedentemente creati.
5 giornata (mar 13 febbraio 2024)
– Le Lionnais, Perec e gli altri membri del movimento dell’”OU.LI.PO.”
– La poesia combinatoria: un’ultima volta ancora sulle cinque regole per l’adattamento di variabilità.
– Gli strumenti per la costruzione di un haiku:
– l’haiku e la sua ispirazione: la meditazione ZEN
– gli haiku e i suoi affini: haiku circolare, senryu, haiga, shahai, ecc.
– ibridazione culturale: come pensa e lavora un “haijin oulipien” o una “haijin oulipienne”
– Laboratorio Creativo:
– ancora sugli haiku dei poeti occidentali: Borges, Lowell, Pound e gli altri.
– Un tentativo ambizioso: scrittura di “haiku oulipistes” a gruppi di tre persone (27 combinazioni).
– riferimenti bibliografici per l’approfondimento
6 giornata (mar 12 marzo 2024)
– Laboratorio Creativo:
– Progettazione di “macchine oulipistes”
– Illustrazione di alcuni metodi di costruzione su carta, cartoncino, legno e altri materiali, delle proprie “macchine oulipistes”.
– Conclusioni e scelta dell’uscita di Aprile (data e luogo)
7 ed ultima giornata: un’uscita all’aperto (ad aprile 2024 da definire)
Usciremo insieme per una breve escursione in un parco cittadino, durante la quale, saremo invitati (a gruppi di due o ambiziosamente di tre!) a percepire con tutti i nostri sensi, durante il percorso, due diversi momenti del “QUI & ORA”, creando ognuno i propri haiku.
Al termine del percorso, tutti insieme, presenteremo e valuteremo le “macchine oulipistes” di ogni gruppo, progettate (ed eventualmente realizzate) nell’incontro di marzo.
Presso: Enoteca letteraria, via San Giovanni in Laterano 81, Roma
Orario: 18-21
Costo: 16 euro (cena compresa).
Iscrizione presso: labonarrativa@bellami.it